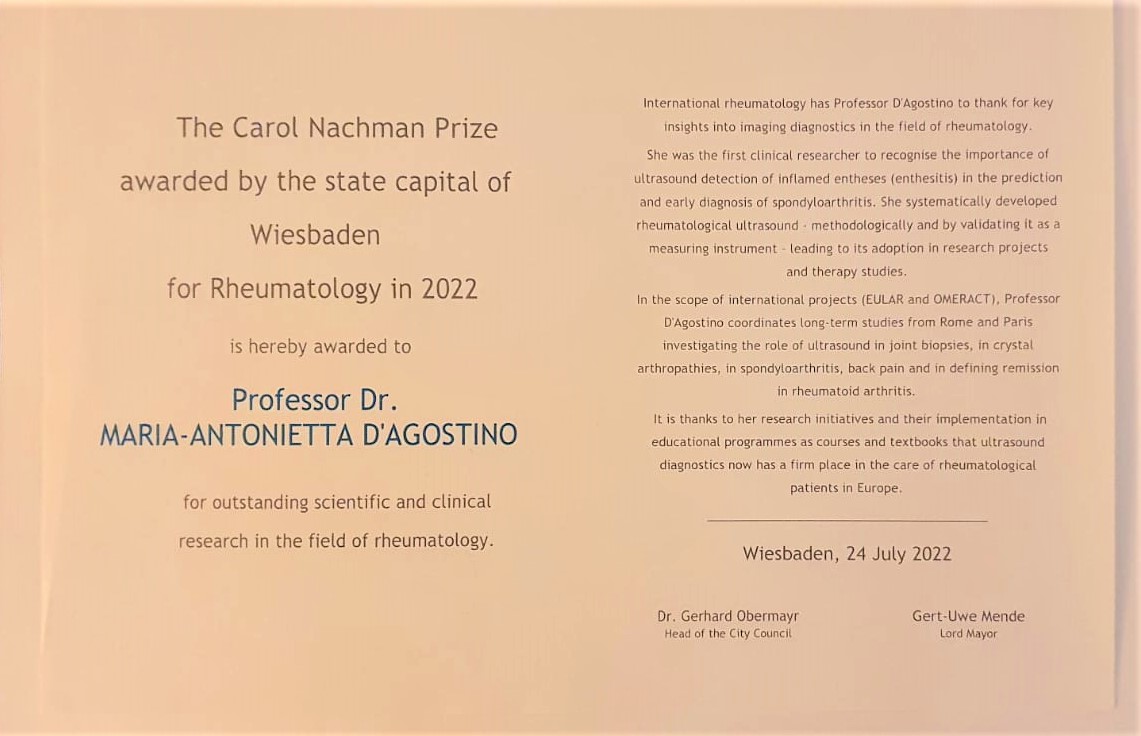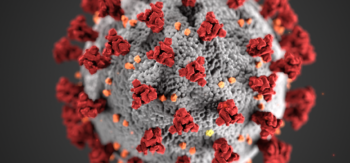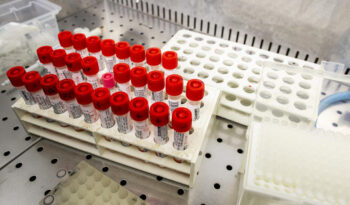COVID-19 Il caso Italia: dal disastro Lombardia, all’eccezionale numero di morti

Una prima analisi dei perché e le lezioni da imparare.
L’Italia è uno dei Paesi che hanno pagato il prezzo più alto in vite umane (comprese quelle degli addetti ai lavori) durante la pandemia di nuovo coronavirus. E alcune regioni hanno pagato il prezzo più alto di tutte: la Lombardia, dove si concentra il 46% di tutti i casi italiani, seguita dall’Emilia Romagna (13%) e il Veneto (9%). Le province di Bergamo, Brescia, Milano e Cremona da sole totalizzano il 33% di tutti i casi italiani. E il numero dei deceduti è di gran lunga il più alto tra tutti i Paesi colpiti. Non è facile trovare una spiegazione al fenomeno ma è fondamentale individuarla per imparare da eventuali errori commessi e prepararsi meglio per il futuro in caso di ulteriori ondate epidemiche. Alcuni ‘fattori di rischio’ di questa strage tutta italiana non sono modificabili. Ad esempio, anche grazie all’eccellenza del nostro servizio sanitario, la popolazione italiana è tra le più longeve del mondo (siamo secondi solo al Giappone) e gli anziani, come è noto, sono i più a rischio di complicanze e di esiti infausti in caso di infezione da SARS Cov-2.

“Ma ci sono tanti altri fattori – scrivono in un articolo su Jama Internal Medicine, il professor Walter Ricciardi e la professoressa Stefania Boccia, Istituto di Igiene, Università Cattolica del Sacro Cuore, insieme a John Ioannidis, Stanford Prevention Research Center (Usa) - che possono aver contribuito al fenomeno e che possono essere modificati”.
L’età mediana degli italiani contagiati è di 62 anni in Italia, contro i 41 della Cina e i 49 della Germania, e l’età mediana dei deceduti per il COVID-19 in Italia è di 80 anni. I soggetti più a rischio di contrarre l’infezione e di morire sono quelli affetti da patologie croniche concomitanti; il fatto di avere in Italia un’elevata percentuale di fumatori con patologie polmonari ostruttive e malattie cardiovascolari, ha comportato una proporzione di soggetti suscettibili all’infezione, ancora più elevata.
Le percentuali di anziani e di persone con patologie croniche sono dunque elementi da tener ben presenti nel disegnare un piano d’emergenza e nello stabilire il numero di letti di terapia intensiva che serviranno per fronteggiare un’evenienza del genere. Nel caso degli Stati Uniti ad esempio, le differenze demografiche sono enormi da Stato a Stato. Si va da una percentuale di over 65 del 9,5% in Alaska, al 19,1% della Florida. In Italia invece gli ultra-65enni rappresentano il 23,1% della popolazione, dato cui si avvicina solo il Giappone.
Il caso Vò
Non è facile determinare con esattezza la percentuale di persone contagiate in una determinata area durante la fase acuta, a meno di non sottoporre tutti a tampone, procedura non congruente con le indicazioni dell’OMS. A Vò, tuttavia, un paesino veneto di 3.300 residenti, tutti i residenti sono stati testati per coronavirus il giorno stesso in cui è stato individuato il primo caso e i risultati hanno mostrato che il 3% della popolazione era effettivamente positiva; la stragrande maggioranza era inoltre assolutamente asintomatica. L’approntamento di rigide misure di contenimento ha permesso di spegnere il fuoco sul nascere.
“Ma di certo – riflette la professoressa Boccia – è verosimile che altrove la prevalenza dell’infezione sia stata molto più elevata e che non siano stati messi in atto interventi di contenimento altrettanto efficaci”. Esemplare al riguardo il caso di Bergamo e dei suoi ospedali, travolti dall’ondata di contagi verosimilmente facilitata dall’evento di massa, riferibile alla partita di Champions League del 19 febbraio (Atlanta-Valencia), alla quale si stima che abbia preso parte un terzo della popolazione di Bergamo.
“E dunque – prosegue la professoressa Boccia – è necessario fare grande attenzione e tenersi pronti in quelle aree dove si sono tenuti eventi che hanno coinvolto un gran numero di persone”.
I letti di terapia intensiva non erano sufficienti
“L’Italia – prosegue la professoressa Boccia – pur avendo un eccellente servizio sanitario, ha un numero di letti di terapia intensiva modesto (5.090 in tutta Italia, cioè 8,4/100.000 abitanti) e pochissimi letti di sub-intensiva (2.601 in tutto, pari a 4,3/100.000 abitanti)”. Tanto per dare un termine di paragone gli USA hanno 36 letti di terapia intensiva ogni 100.000 abitanti. Nel mese di marzo i posti in terapia intensiva sono stati raddoppiati, ma la prima ondata in Lombardia ha sofferto inevitabilmente di una carenza di presidi utili al trattamento appropriato dei casi più severi.
L’inverno non ha aiutato
La stagione invernale è in genere la più critica per il sistema ospedaliero italiano che fa in genere il ‘tutto esaurito’ al picco dell’influenza. All’inizio della pandemia di COVID-19, quando il nemico non aveva ancora un volto e non c’era esperienza in materia, sono stati probabilmente ricoverati in ospedale molti pazienti con sintomi moderati. Quando sono cominciati ad arrivare quelli con sintomi respiratori più importanti, i posti letto erano già in gran parte occupati. E il sovraffollamento degli ospedali spiega in parte anche l’altissimo numero di contagi avvenuto tra il personale sanitario (il 9% di tutti i contagi si è registrato tra il personale sanitario). Un cane che si morde la coda; tutti questi addetti ai lavori in malattia hanno infatti reso ancora più gravosi i turni di quelli restati a combattere nelle trincee dei reparti e delle rianimazioni; ma soprattutto, loro stessi sono diventati veicoli inconsapevoli di contagio e di diffusione dell’infezione.“Ecco perché il COVID-19 – spiega la professoressa Boccia – può essere considerato in Lombardia in larga misura un’infezione nosocomiale, laddove si considerino anche le strutture residenziali assistenziali”. Non a caso, anche il cosiddetto ‘paziente 1’, lo sportivo di Codogno, si era recato ben due volte in pronto soccorso, esponendo al contagio il personale medico e gli altri pazienti in attesa, prima di essere individuato come possibile caso COVID-19.
Il fattore tempo è fondamentale
La risposta del governo centrale all’inizio dell’emergenza è stata rapida ma non rapidissima. Tra il riscontro del ‘paziente 1’ e la chiusura delle 10 cittadine lombarde (Codogno e le altre), dichiarate ‘zona rossa’ sono passati tre giorni. “Le lezioni che si possono ricavare dall’esperienza italiana sono molteplici – commenta la professoressa Boccia – La prima, importantissima, è che bisogna evitare di portare o di far arrivare in ospedale dei pazienti sospetti COVID, a meno che non abbiamo assoluto bisogno di essere ricoverati. E questa lezione è stata messa in atto da molte regioni italiane (come il Veneto e il Lazio) che hanno pressoché da subito gestito l’emergenza con un’efficace rete di servizi territoriali, in collaborazione con gli ospedali, attraverso la sorveglianza attiva dei casi meno gravi e dei relativi contatti. La seconda è di mantenere delle procedure igieniche severissime all’interno dell’ospedale. Infine, è necessario agire rapidamente, in caso di esposizione al contagio di personale medico, per evitare di perdere preziosa forza lavoro”.
Il lockdown ha funzionato?
“Non è facile valutare gli effetti del lockdown senza avere i dati di prevalenza e di incidenza, che saranno disponibili forse dopo indagini sierologiche estese.” Una quarantena forzata ad esempio può portare le persone a spendere più tempo in casa con gli anziani, i più suscettibili all’infezione. “E al momento – prosegue la professoressa Boccia – non è possibile prevedere se ci troveremo di fronte ad una nuova ondata epidemica, una volta rimosse le misure di lockdown”. Le nazioni che hanno implementato da subito un contact tracing aggressivo e test di laboratorio su vasta scala (è il caso di Corea del Sud e Singapore) sembrano rappresentare esempi di un contenimento efficace. E anche l’Italia si sta attrezzando in questo senso, vagliando una serie di proposte di ‘app’ di tracciamento, inviate nel contesto del bando ‘Innova Italia’.
Decessi ‘da’ o ‘con’ SARS CoV-2?
“E’ una domanda questa alla quale non è facile rispondere – conclude la professoressa Boccia – visto che la maggior parte dei decessi è stato registrato in soggetti con almeno un’altra patologia importante (il 98,8% aveva almeno una comorbilità, il 48,3% tre o più)”.
Maria Rita Montebelli