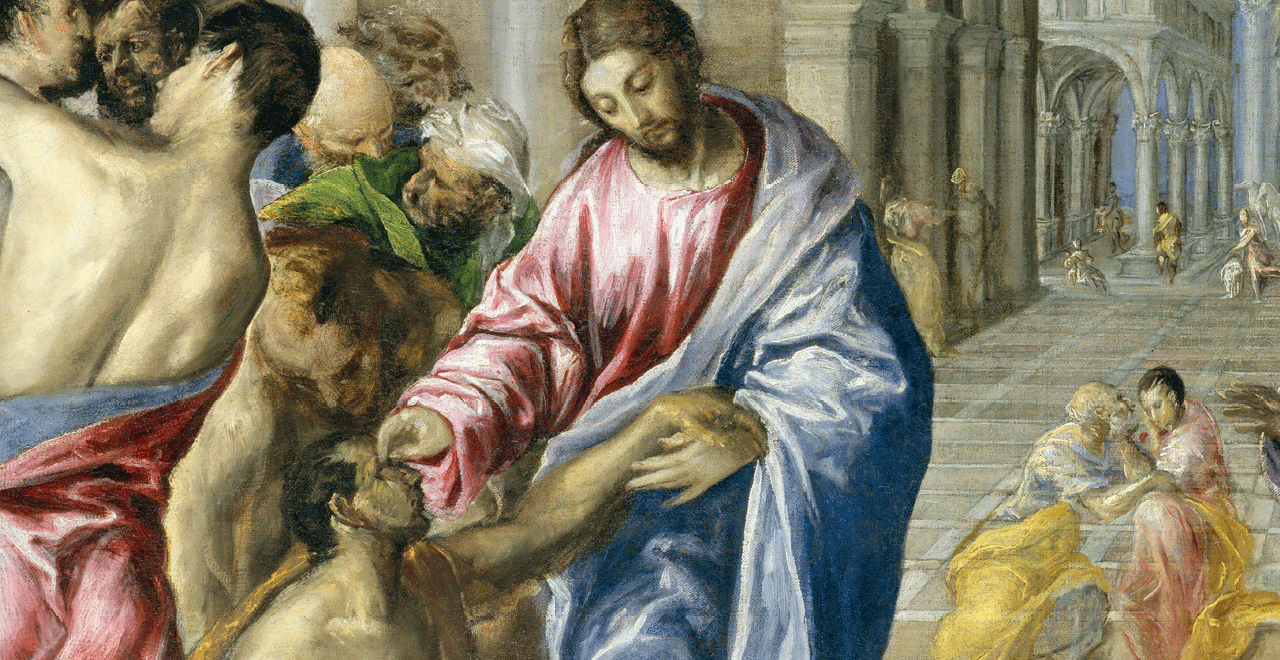La “lezione” del Covid

Verso la Giornata in memoria delle vittime, il 18 marzo, istituita nel 2021. Massimo Antonelli: «È stato importante fare rete. L’aspetto bello? Solidarietà e cooperazione Periodo emotivamente molto forte, le ferite si sentono ancora»
«Un’esperienza molto importante», seppure umanamente «dall’enorme impatto emotivo», che ha permesso di imparare a «essere preparati anche alle situazioni inattese e alle emergenze globali» e dunque a «saper cambiare mentalità». Così Massimo Antonelli, direttore dell’Unità operativa complessa di Anestesia, rianimazione e terapia intensiva del Gemelli e professore ordinario di Anestesiologia e Rianimazione all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, guarda alla pandemia di Covid-19 in occasione della IV Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus – istituita nel 2021 -, che ricorre lunedì 18 marzo. La data ricorda la giornata in cui si registrò il maggior numero di decessi su scala nazionale: il 18 marzo 2020, quando in tv scorrevano le immagini dei camion militari carichi di bare che uscivano da Bergamo. Lunedì 18 dunque, in tutti i luoghi pubblici e privati sarà osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell’epidemia e gli edifici pubblici esporranno le bandiere a mezz’asta.

Professore, nel 2020 il virus ci ha trovati dunque impreparati?
Negli ospedali, dove c’è ad esempio un piano aziendale per affrontare la gestione di un grande afflusso di feriti, per le situazioni pandemiche fino a prima del Covid c’era un piano nazionale, per altro datato, per l’influenza. Per cui da subito, fin dall’inizio che è stato drammatico, abbiamo dovuto imparare a fronteggiare un’emergenza che riguardava un virus ancora totalmente sconosciuto. Straordinario è stato in questo senso il contributo offerto dai colleghi che non erano internisti, come oculisti o ortopedici, che necessitavano però di apprendere delle basilari nozioni e competenze per offrire assistenza ai malati e per poter operare nel reparto di terapia intensiva, rispetto al quale erano digiuni. Ricordo lo sforzo nazionale e internazionale in questa direzione e in particolare un breve corso formativo realizzato via web e promosso dalla Società europea di terapia intensiva con la Comunità europea. Un punto di forza, quindi, è stata la grande collaborazione tra voi medici.
Sì, il fare rete è stato un aspetto molto importante. Nel Lazio si è creata una vera e propria rete di scambio di informazioni semplicemente usando WhatsApp per cui ogni giorno avevamo il polso della situazione e conoscevamo le disponibilità per allocare i malati laddove il nostro reparto fosse pieno; la rete si è formata anche a livello internazionale e questo – insieme alle strategie di intervento apprese e attuate – è un patrimonio straordinario e un’eredità da conservare. Mi ricordo che, essendo stata l’Italia il primo Paese dell’Occidente a essere investito dall’ondata, avevamo ogni giorno tante richieste di informazioni dalla Francia, dall’Inghilterra e dagli Usa. Lei è stato anche membro del primo Comitato tecnico scientifico.
Sì, per un anno e mezzo. Abbiamo dovuto fare i conti con la scarsezza e la penuria delle risorse delle quali c’era una estrema necessità negli ospedali; per esempio ricordo che c’era una grande “fame” di ventilatori meccanici: essendo prodotti da una azienda tedesca, davanti alle tante richieste a venire favorita nelle forniture era la Germania. Questo per dire che in quel periodo si è entrati in una competizione ovviamente non voluta ma in qualche modo inevitabile. Sul piano umano e personale cosa ricorda e cosa resta di quel periodo?
È stato emotivamente molto forte tanto che le ferite si sentono ancora e le cicatrici si portano dietro. All’inizio c’è stata la paura da parte di noi medici di venire contagiati e di non riuscire a ottemperare così alle esigenze dei pazienti; inoltre c’era la preoccupazione nei confronti dei nostri familiari: io a casa ho sempre mangiato e dormito in una stanza separata e mio figlio, che è grande e vive per conto suo, l’ho riabbracciato dopo 3 mesi. Sono cose che segnano. Drammatico è stato poi gestire il rapporto con i pazienti e con i loro familiari a causa delle necessarie restrizioni perché l’impossibilità di guardare i parenti dei malati negli occhi, dovendo comunicare solo telefonicamente o con le videochiamate e avendo unicamente la tonalità della voce come mezzo per creare empatia, rendeva tutto doloroso, specie se si trattava di dover comunicare una notizia tragica. Come ci si sentiva in quei momenti è qualcosa che non si può spiegare ed esprimere: questa è stata la più grande sgradevolezza. Sul lavoro dei medici ha pesato dunque una stanchezza psicologica oltre che fisica.
Nel nostro reparto di terapia intensiva, che normalmente tratta in contemporanea 50 pazienti, siamo arrivati ad averne circa 100 e sono oltre duemila i malati che abbiamo trattato come terapia intensiva durante tutta la pandemia. Ma c’è stato un comune livello di solidarietà e cooperazione a 360 gradi che è l’aspetto bello da ricordare e che di solito non c’è e si perde, stando dietro ai conti e al budget. Va inoltre ricordata la straordinaria abnegazione dei giovani medici specializzandi che hanno dimostrato uno slancio eccezionale, facendosi carico di un lavoro al quale noi, con il solo organico normale, non saremmo stati capaci di fare fronte.